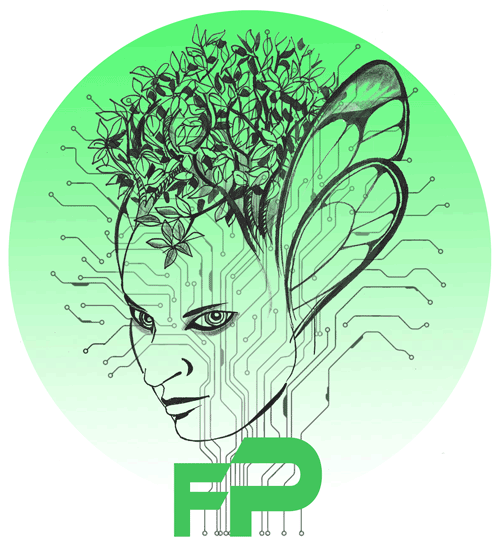da Samuele Strati | Apr 22, 2023 | Autori, Filosofia, Letteratura, Umano
«Se mi chiedessero qual è l’atteggiamento generale nei confronti degli animali che mangiamo, direi: il disprezzo. Li trattiamo male perché li disprezziamo; li disprezziamo perché non si ribellano»
Si provi a seguire J. M. Coetzee nella sua medesima proposta: La vita degli animali (1999) raccoglie le Tanner Lectures di Princeton del 1997-1998, le quali sono tuttavia tenute, e presentate successivamente al lettore, in forma di racconto. La relatrice è Elizabeth Costello, scrittrice, anziana, in visita all’Appleton College per presentare due conferenze sul tema del trattamento che la società riserva agli animali.
La prima, I filosofi e gli animali, contiene la critica al «grande discorso» del pensiero occidentale, il quale altro non sembra essere che una sorta di mitologia della separazione, un racconto sull’origine dell’uomo come opposto dell’animale. È un discorso che esalta la ragione sopra ogni cosa, e che riconosce nella specificità umana il suo principio conservativo. Esso ha decretato l’identità dell’universo e della ragione che lo comprende, escludendo quindi gli animali – nel presupposto che in questi la ragione non alberghi – dalla partecipazione alla natura di questa gloriosa unione. «L’universo è costruito sulla ragione. Dio è un Dio di ragione. Il fatto che grazie alla ragione si possa arrivare a comprendere le leggi che regolano l’universo dimostra che la ragione e l’universo hanno la stessa essenza».
Ma, prosegue Costello, la ragione coincide, al più, con l’uomo. Non l’essenza dell’universo, dunque, ma di chi, grazie ad essa e attraverso essa, lo pensa. Perciò il criterio della razionalità le appare in fondo tautologico: «Certo, la ragione riconosce la validità della ragione in quanto principio primario dell’universo: che altro dovrebbe fare? Detronizzare se stessa? I sistemi razionali, in quanto sistemi di totalità, non hanno quel potere. Se ci fosse una posizione dalla quale la ragione potesse attaccare e detronizzare se stessa, essa l’avrebbe già occupata, altrimenti non sarebbe totale».
Nelle relazioni con gli altri animali si è voluto di nuovo consacrare la validità della ragione adottandola come unità di misura per la valutazione delle loro facoltà cognitive. Qui, forse, Coetzee avanza una delle critiche più interessanti agli esperimenti sulle capacità mentali dei non umani. Nella seconda conferenza, dedicata alla poesia, Costello afferma che sono gli stessi esperimenti a non avere senso, nella misura in cui, strutturati come sono, tentano di rilevare una presenza di astrazione che non corrisponde alla reale comprensione del mondo da parte dell’intelligenza che vi si trova immersa. Tragicamente antropocentrici, in essi si dà importanza a criteri destinati a mancare il bersaglio. «C’è qualcosa di stolido nel modo in cui il behaviorismo scientifico indietreggia di fronte alla complessità della vita». Con altre parole, qualche pagina prima, gli animali vengono spinti «a pensare la cosa meno interessante».
Contestando il famoso esempio del pipistrello di T. Nagel, che si chiedeva «what is it like to be a bat?», la letterata dà la propria soluzione. Al cogito, al pensiero, Costello oppone la pienezza dell’essere, ovvero l’esperienza di essere, la sensazione di essere un corpo vivo, solido, esteso, spazialmente collocato in un mondo in cui perlomeno, se non si possiede astrattamente la nozione di vita, si ha la presenza a sé della propria vita – perciò la protagonista si appella a questo concetto impiegando anche il termine gioia. Ed è una condizione sperimentabile: in prima persona, naturalmente – ma Coetzee è chiaro: non si tratta di chiedersi cosa l’uomo e gli animali abbiano di comune – e per mezzo dell’empatia. Costello risponde alla sconsolatezza di Nagel rinvigorendo pubblicamente la fiducia nella capacità di «entrare col pensiero nell’essere di un altro», che lei dichiara illimitata.
La decisione stilistica di presentare una riflessione nella forma del romanzo ci consente inoltre di ragionare sui personaggi che la formulano. Possiamo dunque provare ad immaginare come debba essere la vita di Elizabeth Costello, che forse non ha visto l’orrore, il miserevole orrore della vita degli animali, e nondimeno sa che esso esiste, e che esiste per lei nella forma persecutoria di un’irrespirabilità generale che le rende ostile ogni spazio – fisico o sociale – e quindi l’esistenza in senso proprio. Quasi che il coltello del macellaio la minacci direttamente ad ogni passo, ad eterno memento di ciò che per sua natura, una volta scoperto, non può essere dimenticato. Costello, in viaggio con il figlio, racconta un’impressione della sua fantasia: mentre si trova a casa di amici, commenta la qualità di una lampada da salotto, per poi scoprire, dalle parole inorgoglite dei suoi ospiti, che questa è fatta con la pelle di un’ebrea polacca. A noi non resta che immaginare una metamorfosi dei volti, improvvisamente fattisi caricature grottesche, e provare un incrollabile desiderio di fuga. Ma la nostra protagonista non ha caricature di fronte a sé: si muove nella società come chiunque, e con la stessa chiarezza con cui sa cosa si conduce nel substrato nascosto della vita civile – il massacro, il crimine, la «guerra agli animali» – sperimenta anche la perfetta normalità dei rapporti.
Il dolore, unito allo smarrimento, all’impossibilità di stare nel luogo in cui ci si trova, conduce ad un avvilente senso di sconfitta. Costello non risulta vincitrice nei suoi incontri all’Appleton College. Non ne risulta neanche perdente, e infine tutto si risolve in un ripristino dello stato iniziale. Le conferenze somigliano a una grande parentesi che rimane significativa solo finché è aperta. Una volta chiusa, la vita riprende in maniera identica a come scorreva in precedenza. John Bernard, il figlio di Costello discute con sua moglie Norma, la quale non ha la scrittrice in simpatia e sopporta con malcelato fastidio la sua presenza. È lui a proferire le parole definitive: quando sua madre se ne sarà andata «torneremo alla normalità». John e Norma non si rivolgono direttamente all’anziana relatrice, eppure la sensazione è che lei li abbia uditi, e che una volta in viaggio confermi con le sue angosce le parole del figlio.
La denuncia di Costello viene freddamente (cortesemente) ricevuta dall’attenzione dell’uditorio, ma non sembra realmente infrangere il muro dell’imperturbabilità. E dove Costello rivela la propria incapacità di comprendere in se stessa la tragica verità sulla vita che gli animali conducono, fuori la reazione è talvolta del tutto ostile. Per Norma, la sua astensione dalla carne è «una fisima nei confronti del cibo» che si traduce rapidamente in un esercizio di potere – salvo poi tradirsi da sé: se questo è un gioco di potere, Norma ne fa parte, temendo segretamente di perdere il proprio, in particolare nei confronti dei figli. «Avrei più rispetto per lei se non cercasse di accoltellarmi alle spalle con le storie che racconta ai bambini sui poveri vitellini e quello che fanno loro gli uomini cattivi. […] È un gioco malsano, non voglio che i bambini lo facciano con me». Ma la parentesi si chiude: dopodiché, Costello torna al suo dolore e al suo smarrimento, ovvero alla condizione da cui il potere non può più essere esercitato.
In più di un punto Coetzee lascia intendere una difficoltà autentica nella ricerca delle ragioni reali dell’orrore. Lo sterminio non sembra rispondere, nella sua vera essenza, alle logiche del mercato, né a quelle della natura. La risposta va forse cercata entro una dimensione spirituale. Quando, durante la cena al Circolo della Facoltà, il rettore le domanda se il suo vegetarianismo abbia un’origine morale, lei risponde negativamente. «Nasce dal desiderio di salvarmi l’anima», dice. L’impressione, triste, è che al contrario la salvezza rifugga Elizabeth Costello, alla quale non rimane che cedere a un pianto sommesso.

da Giulia Girodo | Apr 11, 2023 | Filosofia
Da bambina sono stata qualche volta negli zoo. Ho sempre amato gli animali e vedere dal vivo tigri, elefanti, leoni, serpenti rari e uccelli variopinti significava riempirsi gli occhi della meraviglia della vita e della sua molteplicità di forme e colori. Li guardavo mentre loro se ne stavano lì, tranquilli. Qualcuno passeggiava in cerchio nel suo recinto. Altri stavano stesi all’ombra di un grosso albero e potevo scorgerli soltanto aguzzando bene bene la vista, mentre attraversavo in macchina una vasta zona erbosa a loro dedicata. Erano tranquilli, rilassati, sembravano in buona salute, avevano cibo, acqua, riparo e cure mediche. Nessun visitatore li disturbava, attento a non violare le norme di comportamento dettate dalle guardie e affisse ovunque nello zoo.
Ero una bambina ingenuamente felice, che si godeva la rara gita con i genitori.
Ora sono adulta. Il mio amore per gli animali è rimasto inteso e appassionato, proprio come allora. Però sono cresciuta e con me anche questo amore è maturato e ha preso una forma diversa. Ecco, quello stesso amore, adesso, non mi farebbe mai più mettere piede in uno zoo.
Non è mia intenzione valutare i pro e i contro di queste strutture: lo ha fatto magistralmente Henri Mance nel suo testo Amare gli animali [Mance 2021]. Al capitolo sesto potete trovare un’analisi dettagliata e al contempo accessibile della molteplicità di aspetti che ruotano attorno alla realtà degli zoo: dichiarati scopi conservazionisti, studi sulla diminuzione della fertilità in cattività, analisi delle condizioni di vita in cattività, studio delle implicazioni che catture e trasferimento hanno sulla salute degli animali e sui loro legami sociali.
Lo scopo del presente articolo non è quello di prendere posizione a riguardo, di affermare se gli zoo siano una buona o una cattiva cosa: necessiterebbe di ulteriori approfondimenti e molto più studio. Ciò che mi interessa, in questa sede, è considerare la realtà degli zoo in relazione al tema centrale del blog, ossia lo sguardo degli animali tanto umani quanto non.
Partiamo da un’ovvietà: noi andiamo allo zoo per guardare gli animali. Paghiamo un biglietto per osservarli ed è nell’interesse dei gestori dello zoo permetterci di farlo al meglio: non dobbiamo rimanere a bocca asciutta, lo spettacolo ci deve appagare e soddisfare. Paghiamo per uno spettacolo e questo ci deve essere fornito. Il set, dunque, deve essere fatto in modo da rispondere a due requisiti: da un lato, tenere gli umani separati dagli altri animali per evitare incidenti di qualsiasi natura e, dall’altro, offrire e garantire una buona visuale sullo spettacolo per cui si è venuti fin lì. Ecco allora che la scelta di utilizzare le sbarre per delimitare i luoghi riservati agli animali appare tutt’altro che casuale: esse ci tengono a distanza dall’animale, ma se questo fosse l’unico scopo cui rispondono, perché non una siepe? E no, perché le prime rispondono anche ad un altro tipo di interesse, che le seconde non possono soddisfare: guardarci attraverso, scorgere ciò cui siamo tenuti lontani.
Sicuramente gli zoo moderni sono molto diversi dai primi, inaugurati nel XIX secolo. Come riporta Mance, spesso i recinti per gli animali costruiti nell’800 erano completamente spogli: l’assenza di ostacoli visivi assicurava ai visitatori un’osservazione continua e incondizionata dell’animale detenuto [Mance 2021, p. 256]. Oggi le condizioni sono migliori: come ricordo anche io, gli animali hanno spesso a disposizione grandi appezzamenti di terreno in cui scorrazzare liberamente. Il visitatore può attraversarli soltanto ben chiuso all’interno della propria automobile: è lui, in questo caso, lo straniero, l’ospitato.
Ma se i leoni in natura hanno un territorio tra i 20 e i 400 chilometri quadrati, le tigri indiane tra i 20 e i 150 [Regan 2004, p.191], cosa rappresentano davvero quei grossi recinti che ricordo? Non sono forse solo un compromesso, l’illusione data al visitare di essere di fronte alla natura quando invece non è che un suo surrogato, costruito appositamente per lui? Cosa se ne fa un elefante, che in natura può percorrere fino a 130 chilometri al giorno alla ricerca di cibo [Regan 2004, p.191], di un chilometro quadrato di recinto? (Nota aggiuntiva: il grande recinto attraversato in macchina dei miei ricordi fa parte di uno zoo che ha un’estensione totale di 140 ettari, ossia meno di 1.5 chilometri quadrati.)
Come afferma Jhon Berger, “l’ideologia sottesa è chiara: ad essere osservati sono sempre gli animali. Il fatto che essi possano osservare noi ha perso di importanza” [Berger 1980, p. 17]. Gli zoo sono costruiti per permettere all’umano di osservare gli animali e non tengono in seria considerazione l’esperienza che altri animali fanno di questa realtà.
In primo luogo, è ingenuo pensare che essi non reagiscano alla nostra presenza, agli sguardi continuamente puntati su di loro. Se ci fossimo noi al loro posto, come minimo proveremmo sensazioni di disagio, di mancanza di privacy: vorremmo solo non essere osservati costantemente. È tanto sbagliato pensare che anche un animale non umano possa provare simili sentimenti? No, non credo. Non c’è nessuna differenza rilevante tra noi e loro che permetta di affermare il contrario. Anche gli altri animali hanno organi percettivi, fanno esperienza di ciò che accade loro intorno e, come già affermava Jakob von Uexküll [Uexküll 1934], gli stimoli esterni rappresentano per loro qualcosa, si caricano di un significato. Anche ammesso che non possiamo sapere esattamente cosa provi una scimmia di fronte agli sguardi dei visitatori, che valore preciso essi rivestano per lei, non è possibile disconoscere il fatto che per lei qualcosa significhino. Così come una banana vuol dire ‘cibo’, una palla ‘gioco’ e un conspecifico di sesso opposto ‘possibile partner’, la presenza del visitatore deve dirle qualcosa. Gli animali, insomma, percepiscono, vedono e sentono (con l’udito o l’olfatto che sia) coloro che li osservano e questo è un aspetto rilevante e deve essere preso in considerazione.
Nel 2007 due panda hanno fatto il loro ingresso all’Ocean Park di Hong Kong e i suoi gestori speravano di avere presto dei cuccioli dalla coppia. Fino al 2020, però, i due non hanno mostrato nessun segno di interesse sessuale l’uno per l’altro. Ma poi qualcosa è cambiato e ad aprile 2020 si sono accoppiati per la prima volta. Cosa è successo? ‘Semplice’, il corona virus e con lui la chiusura del parco e l’assenza di visitatori [Mance 2021, pp. 269-270]. Non possiamo sapere con certezza che il fatto che non ci fosse nessuno a guardarli sia stato il motivo per cui i due panda si sono accoppiati, ma è così inverosimile credere che non sentirsi continuamente osservati abbia giocato un ruolo? Dopotutto, anche Vinciane Despret rileva come tutto ciò che sappiamo sulle abitudini sessuali degli animali derivi da osservazioni in cattività. Questo perché è estremamente raro cogliere sul fatto gli animali selvatici in natura. L’atto dell’accoppiamento, infatti, avviene in luoghi appartati, sicuri, lontano dagli sguardi di altri animali e lontano delle rotte di possibili predatori. Tutto questo perché è un momento di estrema vulnerabilità, in cui si abbassano le difese, l’attenzione è focalizzata sul partner e sulla prestazione: non ci si può curare dell’esterno e restare vigili. [Despret 2012, p. 62] Quello dei due panda è solo un esempio ma è utile a suggerirci la necessità di tenere in considerazione il fatto che l’essere osservati gioca un ruolo nel plasmare la conduzione della vita quotidiana degli animali negli zoo. In quanto osservatori, noi esseri umani non siamo nell’etere, non siamo esterni, estranei rispetto a ciò che osserviamo. Osservando provochiamo reazioni, cioè agiamo e provochiamo degli effetti.
Oltre alla considerazione del fatto che i nostri sguardi sugli animali hanno un impatto su di loro e che quindi questi ultimi non ne sono indifferenti, il tema dell’esperienza dell’animale non umano incrocia la riflessione sugli zoo in un altro punto. Non solo essi percepiscono la presenza dei visitatori, ma fanno esperienza anche delle strutture e delle condizioni ambientali in cui si trovano a vivere. Prendere in considerazione tale esperienza significa provare ad osservare la realtà degli zoo con i loro occhi e questo può portare, da un alto, a comprendere come questa deve essere strutturata affinché risponda alle esigenze specifiche dell’animale detenuto, dall’altro lato a comprendere se una struttura come lo zoo possa mai costitutivamente essere adatta alla loro soddisfazione.
Per quanto riguarda il primo punto, esso esprime l’idea che sosteneva il progetto di riforma degli zoo inaugurato in Europa da Heini Hediger (1908–1992): una profonda revisione degli ambienti delle gabbie, dei metodi di trasferimento, delle modalità di mantenimento della vita degli animali, guidata dalle conoscenze etologiche e biologiche [Chrulew 2013, pp. 222-237 ]. L’ambiente dello zoo, secondo Hediger, deve rispondere non solo all’esigenza umana di osservare gli animali, ma a quella degli animali di vivere in un contesto ambientale adatto a loro, adeguato all’esplicazione dei loro predicati vitali specie-specifici. Comprendere l’altro, in questo caso, significa sapere ciò di cui egli ha bisogno per poter costruire un ambiente artificiale il più consono possibile, ossia per poter predisporre artificialmente ogni cosa affinché la vita dell’animale possa essere considerata degna e piena.
Resta, allora, ancora una domanda aperta che fa riferimento al secondo punto: uno zoo, struttura artificiale, chiusa, delimitata, che sussiste grazie ai visitatori che vogliono poter vedere gli animali e agli studiosi che vogliono la stessa cosa per poterli studiare, che raggruppa specie che in natura non si sfiorerebbero mai, potrà mai soddisfare le esigenze degli animali che ospita? Come può avere una vita piena un uccello migratore tenuto in gabbia? La detenzione non rappresenta, di per sé, una sistematica frustrazione dell’autonomia vitale di ogni organismo?
Gli zoo rispondono ad interessi umani ben precisi: sono in grado di prendere in considerazione anche quelli degli altri animali? E se sì, non ci sono forse limiti strutturali alla piena soddisfazione di tali interessi?
Amo gli animali e amo incontrarli. Ma che tipo di incontro è quello che avviene negli zoo, in cui un soggetto piega l’altro costringendolo a mostrarsi sempre e comunque, secondo tempi e modalità dettate dall’essere umano?
RIFERIMENTI
Berger Jhon, About looking, Pantheon Books, New York, 1980. Edizione utilizzata: Sul guardare, ESBMO, Milano, 2003.
Despret Vinciane, Que diraient les animaux si…on leur posait les bonnes questions?, La Découverte, Paris, 2012. Edizione utilizzata: What would animals say if we ask the right question?, trad. di Brett Buchanan, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2016.
Mance Henri, How to Love Animals. In a human-shaped world, Penguin Publishing Group, New York, 2021. Edizione utilizzata: Amare gli animali. Allevamenti, alimentazione, ambiente. Una proposta per convivere con le altre specie, trad. it. a cura di Lorenzo Vetta, Blackie, Milano, 2022.
Matthew Chrulew Preventing and giving death at the zoo: Heini Hediger’s ‘death due to behaviour’, in Animal Death, a cura di Jay Johnston e Fiona Probyn-Rapsey, Sydney University Press, Sydney, 2013, pp. 221-238.
Regan Tom, Empty Cages: Facing the Challenge of Animal Rights, Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, 2004. Edizione utilizzata: Gabbie vuote: la sfida dei diritti animali, Sonda, Casale Monferrato (AL), 2005.
Uexküll Jakob von, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten, Springer, Berlin, 1934. Edizione utilizzata: Ambienti animali e ambienti umani, a cura di Marco Mazzeo, Quodlibet, Macerata, 2019.

da Leonardo Albano | Mar 28, 2023 | Antropologia, Filosofia, New Media, Psicologia, Tecnica
Le cose non sono mai semplicemente “cose”. Essendo situate nel tempo e nello spazio, non si riducono al confine fisico che le attornia. Il loro significato esonda da questi limiti e rimanda costantemente a linee alternative, perpendicolari, tangenti o addirittura parallele, che si dirigono verso panorami semantici ulteriori e ispessiscono la trama della mera cosa in sé. La cosa contiene le tracce di ciò che l’ha attraversata, di ciò che l’ha costruita e di ciò che tutt’ora la brama. La cosa è uno spazio d’incontro, un crocevia trafficatissimo dove fenomeni dapprima irrelati si uniscono in una intimità profonda per articolare il discorso, la narrazione e la storia della cosa stessa.
Le cose hanno storia e per questo non sono indifferenti. Sono comprese in reti relazionali vertiginose, in un rizoma intercontinentale dove nulla è mai realmente isolato. Le cose parlano, testimoniano, respirano l’aria di chi ha interagito con loro; sono incubatori di ricordi e bauli pieni di suggestioni. Sulle cose s’imprimono il passato e l’emotività degli attendenti, le loro attese, i loro progetti, in un linguaggio però ermetico, che non si esprime chiaramente ma sibilando, bisbigliando da un piano dislocato, presente attorno a noi e insieme irraggiungibile. In un certo senso, le cose sono possedute: sono cioè infestate da impressioni, immagini, veri e propri fantasmi che giungono con la nebbia, rendono invisibili le sponde e fanno della cosa un paradosso materiale, una specie di non-morto ontologico di cui non si può decidere la categoria di appartenenza.
Questi fantasmi provengono da tempi diversi dal presente in cui si interagisce con la cosa. Sono gli spettri del passato, carichi di nostalgia, che alludono a tutti gli incontri che la cosa ha avuto nel corso della sua esistenza; e quelli profetici del futuro, che già annunciano la fine che la cosa incontrerà e le conseguenze che innescherà la sua distruzione. I fantasmi viaggiano tra le dimensioni temporali e così il significato delle cose. Le loro stesse denominazioni, la funzione e il valore che vengono loro attribuiti non restano contenute nell’alveo del presente, ma straripano e scorrono in tutti gli altri piani temporali possibili. Il fantasma è, sinteticamente, un’esperienza totale della cosa; non il fruire di essa, ma l’ascoltare la sua voce, l’evocare la sua complessità sottesa, il lasciarsi ispirare dai racconti delle sue innumerevoli avventure.
Questa considerazione sulla natura della cosa – il suo essere infestata, il suo essere un morto inquieto – comporta un certo tipo di etica, di maniera di amministrare la cosa, che rifiuta, anzitutto, di ridurre la cosa a uno stadio di purezza. Quest’etica, anzi, si volta dall’altra parte e guarda il percorso in salita: non abbandona, puntando verso la valle, il vasto panorama che si intravede sulla cima, così rigoglioso di dettagli e di relazionalità, ma torna indietro verso di esso, agogna a raggiungerlo nuovamente, e questo ogni volta che le occorre usare una cosa. Che significa quindi “usare”? Il concetto qui s’impregna di un senso ulteriore di responsabilità: prima di usare una cosa, prima di stabilire per quale scopo debba essere impiegata, dovrò prima ascoltare la sua storia per decidere poi, assieme ad essa, se merita effettivamente di essere impiegata. Si tratta di un’etica del consumo della cosa: come posso consumare al meglio una cosa che non è semplicemente cosa? E a un livello metaforico: come posso mangiare qualcosa che parla?
La risposta può essere lunghissima come molto succinta. Diremmo che per ora sarebbe sufficiente mangiare senza ingozzarsi, nutrirsi con rispetto, pensando ai leoni nella savana che si accontentano di un solo esemplare di antilope, senza sterminarli indiscriminatamente. Il problema fondamentale è un altro: i fantasmi non emergono se non li interrogo. Se io uso una cosa semplicemente, se la sfrutto senza pormi il problema di ascoltare la sua storia, i fantasmi che la posseggono non si manifesteranno mai. La visione del rizoma mi rimarrà preclusa e continuerò a sfruttare le cose, diremmo ora il piano materiale, senza cognizione del male che le sto facendo. Non ascoltare una voce, ignorare cioè il racconto dell’altro, la complessità che lo caratterizza, equivale a un atto malvagio: sto impedendo l’epifania, sto ostacolando la verità, mi tappo le orecchie per continuare ad alimentare una relazione univoca con la cosa, di cui io-agente decido i contenuti.
Se l’apparizione dei fantasmi non viene da sé, significa che in certi casi essi rimangano inascoltati, costretti a una relazione univoca con il loro fruitore in cui essi non possiedono margine di iniziativa. Una situazione come questa si dà in molti contesti che per noi sono quotidiani: quando facciamo la spesa, quando acquistiamo l’ultima novità tecnologica o compriamo degli abiti nuovi. Nella maggior parte dei casi, i fantasmi che infestano le cose pertinenti a queste situazioni vengono ignorati per far scivolare con facilità la transazione. Se si interpellassero ogni volta i fantasmi delle cose, e questo dando anche adito a quel che ci dicono, per molti comprare qualcosa diverrebbe un problema spinoso, una questione morale di alto livello. Come poter comprare infatti qualcosa dopo aver sentito dai fantasmi che la infestano le storie orribili sui materiali che la compongono, sulle mani che l’hanno costruita e sulle logiche economiche che hanno sostenuto il suo viaggio?
Dovremmo estendere questa riflessione alla struttura stessa della civiltà. La civiltà umana deve interfacciarsi con la cosa e deciderne il destino: ricordo ad esempio la cerimonia del potlach, famoso esempio etnografico di gestione dell’eccedenza, o, come ho detto prima, di amministrazione della cosa. Ogni civiltà trova, conscia o meno, un canale preferenziale in cui incanalare le modalità di interazione con la cosa. La civiltà occidentale, in questo discorso, sembra aver arrogantemente accantonato l’importanza di questa relazione, per rovesciarla in un dominio assoluto dove l’individuo stabilisce in partenza che la cosa è solo una cosa, un contenitore vuoto e neutrale su cui indirizzare il proprio desiderio. Non è tanto da guardare al singolo consumatore, che acquista verdura importata e confezioni di plastica al supermercato (spesso è perché le alternative sono poche, costose e impegnative); il focus dev’esser spostato sull’intero apparato di amministrazione della cosa, sulla categoria principale che la società occidentale contemporanea ha imposto come fondamento di ogni altra operazione interna a questo settore. L’economia capitalista ignora il fantasma: lo nasconde e lo esorcizza per proseguire la sua impresa, per convincere la storia di non esser perseguitato, e così, tramite i fasti dell’innovazione e i colori della pubblicità, sotterra il non-morto perché le sue grida non si sentano e la cementificazione, la deforestazione e lo sfruttamento intensivo possano continuare.
Il capitalismo ignora il fantasma e così svuota il mondo stesso della sua peculiarità: il fatto di esser infestato. Il mondo è tale proprio perché infestato e così ignorare l’infestazione, la pluralità di volti e voci che si agitano negli spazi aerei tra di noi, porta a dimenticarne la verità, il fatto che cioè niente è semplicemente quello che è. Il capitalismo ha distrutto il mistero della cosa: essa è chiaramente quello che è – merce, crudezza, cadavere semantico. Invece, l’etica che s’impernia sull’ascolto dei fantasmi, che è dunque ascolto della verità del mondo e della sua essenza, ritorna a quel mistero: torna a chiedersi chi ha fatto quella cosa, con quali materiali, dove, in quali condizioni, secondo quale progetto, e poi agisce nella prospettiva di portare un cambiamento in positivo. Così il capitalismo rinuncia a quest’etica per perpetrare la sua campagna di censura e generare le illusioni del benessere. È l’assenza di etica a generare queste illusioni: la sua presenza invece genera realtà per il semplice fatto che proprio la realtà è la condizione che esige.
In conclusione, voglio indicare una strada: l’etica che si premura di ascoltare i fantasmi è un’etica che apre i suoi confini perché va al di là della storia singola. È un’etica distruttiva perché sgretola la centralità storica in nome di tutte le altre storie, senza tuttavia escludere la sua di partenza. La pone anzi nel mezzo, per osservare le relazioni che essa mantiene con le altre. In questa prospettiva, è un’etica postumana: sostituisce il carattere tracotante, la hybris, del rapporto di dominio, con l’aidos, l’umiltà, nella consapevolezza che il centro, l’individuo e la cosa non sono più (mai stati) universi isolati e che invece figurano nella comunanza paritaria con ogni altra voce. Si scopre così un nuovo interesse “aperto alla con-divisione dello spazio-mondo e alla responsabilità orizzontale” (Revelli, 2020), un’etica che guarda al “post” del classico umanesimo, a un’epoca di storie concertate e fantasmi rispettati, poco turbolenti. Perché ora i fantasmi sono furiosi, latori di messaggi infausti dal futuro e testimoni di crudeltà che, sebbene presenti, rimangono sotterranee. Il passaggio alla cultura postumana è forse l’unica possibilità rimastaci per quietarli, che significa: trasferirsi in uno spazio dove i mondi sono plurali e ambigui e sconfinano innegabilmente, per premessa teoretica, gli uni negli altri, pur mantenendo l’umanità che ci contraddistingue, in tutte le sue innumerevoli ramificazioni.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
- COVERLEY, M., 2020, Introduction, in Ghosts of Future Pasts, OldCastle Books, Harpenden.
- FISHER, M., 2019, Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti, Minimum Fax, Roma.
- FISHER, M., 2013, The Metaphysics of Crackle: Afrofuturism and Hauntology, in Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture, vol.5, n.2, pp.42-45.
- FISHER, M., 2012, What is Hauntology?, in Film Quarterly, vol.66, n.1, University of California Press, Oakland, pp.16-24.
- MORTON, T., 2017, Solidariety with Non-Human People, London, Verso Ed.
- REVELLI, M., 2020, Umano Inumano Postumano, Milano, Einaudi

da Giulia Girodo | Mar 20, 2023 | Filosofia
“Correlazionismo significa che esistono cose in sé, ma che queste non sono ‘attualizzate’ fino a quando non sono messe in relazione da un correlatore (…). Per poter diventare reale, il correlato richiede insomma un correlatore: sicuramente le cose esistono in una qualche sfera inaccessibile, ma non sono propriamente reali fino a quando un correlatore non vi ha accesso” [Morton 2017, p. 18].

Timothy Morton
Timothy Morton, filosofo londinese nato nel 1968, spiega con queste parole il nucleo fondamentale di quella teoria filosofica che, a partire dalla formulazione di Immanuel Kant, ha segnato profondamente tutta la riflessione a lui successiva. L’idea espressa dal correlazionismo è chiara e piuttosto intuitiva, per lo meno nella sua formulazione base: le cose non sono come ci appaiono, il soggetto che le esperisce ha a che fare con esse solo attraverso il medium del proprio pensiero e dei propri organi percettivi. Nessuno è in grado di percepire un oggetto come è in sé, ossia come è a prescindere dalla mente e dagli organi di colui che lo coglie, ma a sempre a che fare con la sua apparenza. Viene così a crearsi un abisso incolmabile tra realtà e apparenza, tra cosa in sé e cosa così come viene percepita, tra mondo e soggetto umano.
Morton nota come la filosofia successiva a Kant abbia reagito a questa ‘scoperta’ cercando proprio di colmare questo profondo abisso. Una strategia elaborata per farlo è stata quella di spostare tutto l’onere della prova sul correlatore: è il soggetto che fa esperienza a dare realtà alle cose; gli oggetti esistono solo nella misura in cui sono colti da qualcuno. La realtà viene, perciò, schiacciata e fatta a coincidere con l’apparenza: solo quest’ultima esiste, è consistente e reale. Tale intuizione, però, può funzionare ed evitare il relativismo (ossia evitare di credere nell’esistenza di tante realtà quanti sono i soggetti che la colgono) solo se assume l’esistenza di un solo ed unico correlatore possibile: l’essere umano. Così il ‘correlazionismo forte’ si fa antropocentrico: l’essere umano è l’unico giudice in grado di stabilire la realtà e il valore che le cose possiedono. Tutto si riduce a ciò che l’uomo vede e percepisce; gli oggetti perdono qualsiasi statuto ontologico proprio, ossia a prescindere e fuori dalla percezione umana, ma sono reali solo in quanto colti dal pensiero umano.
Se gli oggetti non hanno una consistenza propria al di fuori della percezione umana, allora l’uomo può plasmare, fare e disporre degli oggetti cosa e come vuole; se le cose non hanno uno statuto proprio a prescindere dell’essere umano, allora egli ha un potere assoluto su ogni cosa lui esterna. Ciò significa anche che l’unico valore e l’unica funzione che le cose hanno è quella loro assegnata dall’uomo: il legno di cui è fatto un tavolo diventa reale solo nella misura in cui viene lavorato dall’uomo e investito di una funzione, prettamente antropocentrica. Il tavolo è reale, poi, perché ha uno scopo, un valore d’uso legato ai bisogni umani.
L’esito del correlazionsmo forte è, perciò, l’idea di una “privatizzazione” umana “dell’accesso al reale” [Morton 2017, p. 33].
Morton suggerisce, però, che la deriva antropocentrica non è l’unico esito possibile dell’intuizione correlazionista kantiana: è possibile sostenere che alle cose in sé nessun soggetto ha accesso, che inevitabilmente ognuno è costretto a passare attraverso i propri organi percettivi per cogliere le cose esterne, che per il soggetto la realtà è ciò che coglie nel modo in cui lo coglie, senza credere, però, che l’uomo sia l’unico soggetto correlatore possibile e che quindi la realtà coincida con l’apparenza che lui ha del mondo.

Edizione italiana di “Ambienti animali e ambienti umani”
Le riflessioni di Jakob von Uexküll, biologo estone vissuto a cavallo tra 800 e 900, contenute nel testo Ambienti animali e ambienti umani sono calzanti per la riflessione che stiamo conducendo e intersecano la riflessione di Morton su un punto ben preciso: il biologo estone, infatti, attraverso i suoi studi arriva a sostenere che ogni essere vivente, a prescindere dalla specie di appartenenza, è un correlatore. Prima di proseguire, però, è bene concordare e chiarire l’uso di alcuni termini utilizzati: parlerò di ‘mondo’ come di ciò che tutti gli esseri condividono, di ciò che sta ‘dietro’ le percezioni (simile alla cosa in sé kantiana, anche se ne rivedremo il concetto); per ‘realtà’, invece, intendo questo mondo come appare ad un soggetto specifico. Ciò che è reale, dunque, è sempre relativo ad un correlatore che percepisce il mondo.
L’idea che il correlatore possa essere solo umano è piuttosto ingenua: nei suoi studi, Uexküll nota come ciascun animale abbia degli organi sensoriali attraverso i quali percepisce il e agisce nel mondo. Ogni organismo, però, lo fa a modo proprio: sono gli organi di cui è dotato ad avere la funzione di a-priori dell’esperienza. Questi ultimi, cioè, filtrano gli stimoli provenienti dall’esterno e permettono in tal modo un accesso al mondo limitato e selettivo, funzionale alla vita del soggetto. Per esempio, l’essere umano ha accesso solo a determinati stimoli uditivi e visivi; per una zecca il mondo si riduce a pochi stimoli chimici connessi alla sua preda (essa percepisce l’acido butirrico del sudore dei mammiferi, il caldo del contatto con il loro pelo ma non ha alcuna percezione dell’intero corpo della preda). Gli organi di un soggetto, insomma, permettono l’accesso a ciò che del mondo esterno è funzionale alla conservazione della vita, mentre escludono quegli stimoli che rappresenterebbero un disturbo e renderebbero la realtà di ciascuno un caos affollato di input inutili.
Organi diversi determinano accessi e letture differenti del mondo: il pipistrello si orienta grazie a onde sonore che corrispondo per lui ad oggetti e ostacoli esterni, mentre l’essere umano non li percepisce, non ne ha accesso e privilegia, invece, la vista. I due soggetti hanno sicuramente immagini del mondo molto differenti tra loro. Allo stesso modo, organi simili ma con costituzioni differenti determinano percezioni differenti della stessa situazione spazio-temporale: in base al numero di elementi ottici presenti nell’occhio (ossia di ‘sensori’ in grado di captare uno stimolo) varia la risoluzione dell’immagine che si ha del mondo: ad un maggior numero di sensori corrisponde un’immagine più ricca di dettagli.
Per soggetti diversi, dunque, ad essere reali sono immagini del mondo differenti tra di loro: tali immagini sono definite da Uexküll Umwelten, ossia ‘ambienti’. L’ambiente è il mondo così come appare ad un soggetto, ossia la realtà stessa per quell’organismo. Le coordinate e i tratti strutturali di ciascuna Umwelt sono determinati dalla conformazione degli organi percettivi del soggetto e sono connessi all’appartenenza di specie: specie differenti dotano gli individui di organi diversi che determinano una modalità specifica di accesso al mondo. Le Umwelten di due gatti hanno le stesse coordinate, gli stessi tratti generali, così come le Umwelten umane sono simili tra di loro. Quanto più due individui appartengono a specie lontane nella filogenesi, ossia presentano strumenti di percezione quanto più differenti, tanto più le loro Umwelten sono incommensurabili.
Dall’altro lato, però, anche conspecifici vivono in Umwelten differenti e questo è dovuto al fatto che ogni individuo è un unico e singolare punto di osservazione sul mondo: la prospettiva di ognuno è irripetibile perché condotta da un punto di individuazione spazio-temporale unico, privato e incondivisibile. Bisogni e interessi personali guidano ogni soggetto nel mondo e fanno sì che il suo ambiente si colori di tonalità fortemente soggettive: ogni individuo, cioè, assegna un valore personale agli oggetti che esperisce.
Il valore di un oggetto, quindi, è in primo luogo determinato dall’appartenenza di specie: come si è già visto, per l’essere umano lo stimolo chimico dell’acido butirrico non esiste, per la zecca ha un valore biologico fondamentale. Ma in secondo luogo, sono i bisogni e gli interessi personali ad attribuire valori unici agli oggetti e tale valore varia al variare sia del soggetto sia delle condizioni emotive e ambientali in cui lo stesso vive. Per esempio, Uexküll nota come per uno stesso paguro un’anemone possa assumere valori differenti a seconda della tonalità emotiva del primo e della situazione contingente in cui è posto: nel caso in cui il paguro sia sprovvisto di protezioni e si senta minacciato da un predatore, egli colloca l’anemone sulla propria conchiglia per ricevere protezione, mostrando così che essa ha per lui un valore difensivo. Se invece il paguro è già protetto da anemoni, questa assumerà un valore abitativo, fatto osservabile dal tentativo del paguro di entrarvi dentro. Nel caso, infine, in cui il paguro sia affamato, l’anemone avrà per lui un valore nutritivo e inizierà a mangiarla [Uexküll 1934, pp. 104-105].
Gli studi e le riflessioni di Uexküll, dunque, suggeriscono che ogni essere vivente è un correlatore, ossia percepisce il mondo esterno secondo una sua modalità peculiare, ha a che fare solo con ciò che viene filtrato e plasmato dai suoi organi, ossia mai con le cose come sono al di fuori della percezione che ne ha. Ognuno, dunque, ha accesso al mondo in maniera personale e specifica e questo significa che esistono modalità di accesso al mondo non umane e che queste non sono meno vere e meno reali di quelle antropomorfiche: ogni ambiente è reale per il soggetto che lo abita. Non esiste una sola realtà, né una più vera delle altre, ma tutte sono poste sullo stesso piano nel fare riferimento ad un soggetto unico di volta in volta. Non esiste un solo mondo di percepire le cose e gli oggetti non hanno un solo valore possibile: stessi oggetti in ambienti diversi assumono aspetti e valori differenti a seconda del soggetto che ne fa esperienza.
Tutto questo, però, non significa che l’Umwelt sia una costruzione totalmente arbitraria del soggetto: esiste un mondo oggettivo ‘dietro’ le Umwelten che pone limiti, resistenze, freni, novità ed ostacoli che eccedono gli apparati cognitivi del soggetto [Marchesini 2019, pp. 120-130]. Il mondo non si lascia plasmare e leggere in qualsiasi modalità, ma pone freni all’attività percettiva di ognuno: che lo vogliamo o no, indipendentemente da come li percepiamo, una pietra non è un albero. In questo senso Morton può affermare che realtà (mondo) e apparenza (Umwelt) scivolano l’uno sull’altro: l’apparenza non è il mondo, è legata ad una modalità specifica di accesso a questo, ne è una lettura personale, ma non è mai arbitraria. L’apparenza è una sorta di compromesso con il mondo. Quest’ultimo ha una sua consistenza e realtà che è quella di un essere poroso e virtuale, che si rende disponibile a letture e interpretazioni diverse. Il mondo eccede qualunque apparto percettivo; nessuna modalità di accesso alle cose lo esaurisce, ma ne rappresenta una lettura parziale. Le Umwelten sono prospettive tutte parimenti limitate del mondo, piani di lettura specifici, modi di percepirlo parziali e incompleti.
Il mondo è ciò che accomuna tutti gli esseri, che sfugge a tutte le sue possibili letture, che si ritrae ma che è anche condiviso. Sono proprio questa condivisione e l’ammissione del carattere parziale e relativo di ogni percezione le condizioni di possibilità della solidarietà tra tutti gli esseri viventi, ossia anche oltre l’umano: le Umwelten sono sì diverse, ma tutte gettate su un mondo comune che nessuna modalità di accesso esaurisce. La solidarietà estesa ai non umani è possibile se l’essere umano comprende che non è lui il solo correlatore possibile ma che ogni organismo, a prescindere dall’appartenenza di specie, ha un acceso personale e limitato su un mondo comune. Noi esseri umani, correlatori limitati e dai tratti specifici, siamo in grado di provare solidarietà verso ogni altro essere che vive in un ambiente proprio, povero, limitato, difettoso e manchevole tanto quanto il nostro nei confronti di un mondo che sfugge a tutti noi.
RIFERIMENTI
Morton Timothy, Humankind: Solidarity with Non-Human People, 2017, Verso, London. Edizione utilizzata: Humankind: solidarietà ai non-umani, a cura di Vincenzo Santarcangelo, Nero, Roma, 2022.
Uexküll Jakob von, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch
unsichtbarer Welten, Springer, Berlin, 1934. Edizione utilizzata: Ambienti animali e ambienti
umani, a cura di Marco Mazzeo, Quodlibet, Macerata, 2019.
Marchesini Roberto, Alterità. L’identità come relazione, Mucchi, Modena, 2019.

da Giulia Girodo | Mar 6, 2023 | Uncategorized
Benvenuti e benvenute su “vis-à-vis”, il blog gestito da me, Giulia, dottoressa in Filosofia, amante della vita, in ogni sua forma ed espressione.
Perché questo nome? Perché “vis-à-vis” significa “faccia a faccia” ed è di questo tipo di relazioni che il blog si vuole occupare. Ci si chiederà qual è il significato e cosa succede nel momento in cui due paia di occhi si incrociano. Che relazione è questa? Fragile, sfuggente, cosa ci dice sui proprietari di quegli sguardi? E poi, cosa si dicono due sguardi mentre si fissano? Diversi e distanti, eppure sono in gradi di comunicarsi qualcosa anche attraverso il silenzio.
Ma più nello specifico, “vis-à-vis” vuol essere uno spazio di discussione e approfondimento di quelle relazioni che coinvolgono volti dai tratti radicalmente differenti: facce appartenenti ad animali di specie eterogenee, tra le quali l’impossibilità di comunicare linguisticamente sembra tracciare un abisso di incomprensione.
Personalmente sono convinta, sulla scia di Jacques Derrida [2006, pp. 48-51] e John Berger [1980, p. 17], che attualmente noi esseri umani ci concepiamo prevalentemente come ‘osservatori’ del mondo e degli altri esseri viventi, ma che facciamo fatica a riconoscerci anche come ‘osservati’. Ci risulta difficile acquisire e mantenere viva la consapevolezza di essere a nostra volta guardati dagli esseri viventi che ci circondano. Magari sappiamo che il nostro cane ci osserva, ci segue con lo sguardo, ma è un tipo di sapere vago e superficiale, non una consapevolezza così profonda e radicata da essere in grado di influire sul nostro modo di agire e vivere. Solo occasionalmente teniamo davvero in conto lo sguardo animale su di noi, solo di rado ne siamo così profondamente consapevoli da sentire sulla nostra pelle, vivamente, di essere osservati e da plasmare il nostro di agire di conseguenza. Forse ne abbiamo profonda contezza solo nello sfuggente momento in cui incrociamo i loro occhi e questi ultimi ricambiano il nostro sguardo.
Sarà interessante, allora, chiedersi cosa avviene in questo scambio di sguardi. Cosa ci rivela l’occhio vigile che abbiamo davanti, l’occhio che sostiene e ricambia il nostro sguardo? Cosa ci dice del suo proprietario? Ma anche cosa ci dice su di noi: chi siamo per il nostro cane? Che significato abbiamo per l’animale che ci sta di fronte? E, ancora, cosa ci rivela il fatto che agli occhi dell’altro assumiamo un significato che non abbiamo il potere di determinare e scegliere e forse neppure di decifrare?
Ma perché interessarsi a tutto questo e seguirmi? Perché sono convita del potenziale trasformativo di questa consapevolezza. Sono convita che se fossimo più sensibili rispetto a questo, se portassimo sempre con noi la consapevolezza viva di essere osservati dagli altri esseri viventi, allora in primo luogo cambierebbe il nostro modo di concettualizzare i non umani: non più lontani da noi, fuori dalle faccende e dal mondo umani, totalmente estranei; non più macchine, ‘cose’ che si muovono reagendo agli stimoli esterni, ma soggetti autonomi in grado di dirigere liberamente i propri occhi su un mondo che coabitiamo. L’autonoma capacità di osservare dell’altro essere vivente ci dice che egli vive e legge in modo personale e unico la realtà che ci accomuna, che ha su di essa un punto di osservazione irripetibile. Come appare il mondo ai suoi occhi? E se appare diverso, allora cos’è la ‘realtà’? Esiste un modo unico, vero e corretto di osservare il mondo? Quello umano è l’unico modo possibile o il ‘migliore’ di abitarlo?
In secondo luogo, cambierebbe anche il modo di relazionarsi agli altri animali: se ogni essere vivente è uno paio di occhi autonomo che ci guarda e che quindi sta lì da prima che lo osserviamo noi e indipendentemente da noi, allora la sua stessa esistenza è indipendente dall’uomo. Questo significa che ogni essere vivente possiede una vita propria irriducibile ed eccedente ad ogni ‘uso’ umano, ad ogni funzione che egli riveste per l’uomo. Nel suo esserci e vivere indipendentemente da noi, nel suo condurre una vita propria, ogni animale ha una propria identità che eccede ogni categoria funzionale l’uomo gli proietti addosso e che non può essere ridotta a mezzo per la soddisfazione di bisogni umani. Il nostro cane è un figlio per il genitore, un padre o una madre per i suoi piccoli, un pericolo per il gatto del nostro vicino di casa, un compagno di giochi per il cane che incontra tutte le mattine al parco, non solo un nostro pet. Allo stesso modo un maiale è molto di più che non solo carne, un topo che non solo cavia e un elefante che non solo oggetto di interesse in uno zoo.
In terzo luogo, sapersi osservati significa anche tenere in conto il fatto che le nostre azioni sono viste, vissute sulla pelle e interpretate dagli altri esseri: questi ultimi, cioè, non ne sono indifferenti. Le azioni umane hanno un impatto sulle loro esistenze e perciò si caricano di un significato ulteriore rispetto quello che viene loro attribuito dall’uomo. Quando percepiscono, gli esseri viventi attribuiscono significati alle sensazioni, i quali sono legati alla loro personalità, al loro stato emotivo contingente, ai loro bisogni e interessi specifici. Agli occhi di un cane come appare e cosa significa il nostro rientro a casa? E la costruzione di un’autostrada agli occhi del cervo che abita quel territorio?
Tutto questo significa, allora, che agendo l’uomo deve tenere in considerazione l’esperienza che altre vite fanno delle sue azioni: è necessario, cioè, riconsiderare le azioni umane alla luce di occhi, sguardi e significati che umani non sono.
Concludo con una nota metodologica che serve soprattutto a me, come campanellino da tener sempre presente: nell’affrontare i vari temi è necessario tener conto del fatto che la stessa indagine sulla relazione tra due volti non è oggettiva. Essa non è condotta da uno spettatore assoluto, bensì da un essere umano e questo è tanto inevitabile quanto fondamentale da tener presente. Ogni indagine, dunque, soffrirà di limiti, pregiudizi, precomprensioni, categorie che non appartengono al fenomeno in sé, ma a me, Giulia, essere umano che lo indaga. Di certo è un limite, ma imprescindibile e inaggirabile, e che può essere anche un punto di forza e di onestà intellettuale se se ne tiene conto continuativamente.
Con questa breve introduzione e presentazione spero di avervi almeno incuriosito e che sia la curiosità a spingervi a seguirmi in un percorso, questo, che non vuol affatto essere l’esposizione di verità ma una ricerca, un continuo domandarsi, mettersi in discussione, cambiare prospettiva e osservare ciò che si rivela. Cercare di comprendere meglio le relazioni umani-non umani assumendo sempre nuovi e inattesi punti di osservazione e, attraverso questi, cercare di ridefinire le coordinate della concezione e delle azioni che l’essere umano riserva agli altri esseri viventi: questo è lo scopo.
Se cercate verità non le troverete, se cercate risposte definitive non le troverete.
Troverete domande e interrogatavi che agitano e muovono una mente che non si vuole accontentare, una mente che crede solo nel potenziale trasformativo del pensiero.
RIFERIMENTI:
Derrida Jacques, L’Animal que donc je suis, Galilée, Paris, 2006. Edizione utilizzata: L’animale che dunque sono, a cura di Massimo Zannini, Rusconi, Santarcangelo di Romagna, 2020.
John Berger, About looking, Writers and readers company, London, 1980. Edizione utilizzata: Sul guardare, a cura di Maria Nadotti, Mondandori, Milano, 2003.