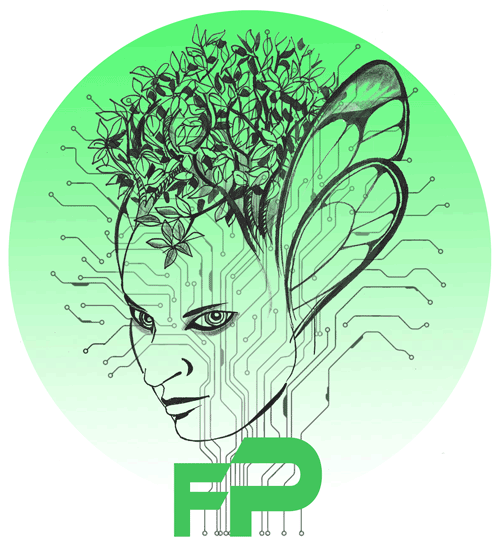da Samuele Strati | Set 13, 2023 | Uncategorized
Dr. Pascolini, il suo ultimo lavoro, Le sepolture animali nelle necropoli longobarde. Offerte Funebri e Riti Sacrificali (Daidalos, Umbertide 2023), indaga gli aspetti sociali, culturali e religiosi delle sepolture animali (equine, e più limitatamente canine) durante il primo trentennio di presenza longobarda in Italia (568-598 d.C.). Per introdurci, iniziamo dal rito funebre, che lei descrive come una cerimonia pubblica attraversata da forti motivi identitari, nonché una vivace occasione di condivisione orale, in cui il gruppo parentale poteva legittimamente raccogliere lo status sociale del defunto di fronte al resto della comunità. Su due aspetti ci vorremmo soffermare: la funzione di tutela della memoria collettiva e del sapere comune assunta dalla necropoli in un momento di necessaria rielaborazione culturale, quale doveva essere stata la migrazione dalle aree pannoniche, e la scarsa attenzione che il rito, secondo la sua analisi, sembra riservare alla prosecuzione ultraterrena della vita dei defunti.
Nella società longobarda, la necropoli costituiva un importante punto di contatto tra il mondo dei vivi e la comunità dei morti, due realtà legate tra loro da un rapporto di omologia. La presenza di una ritualità associata alla deposizione di resti umani in spazi socialmente definiti e riconosciuti pare costituire un elemento fondamentale nella creazione di una dimensione sociale della memoria e nel conseguente sviluppo di una qualche forma di culto degli antenati. Inoltre, la necessità di riorganizzare socialmente ed economicamente la comunità in seguito ad un evento di enorme portata come il processo migratorio, aveva generato una certa particolarità nella distribuzione spaziale delle tombe, volta ad enfatizzare i vincoli di parentela e di discendenza esistenti tra i defunti. Il gruppo umano longobardo appare molto poco interessato all’aldilà. Le stesse caratteristiche denunciate dal cerimoniale funebre mostrano infatti come l’attenzione fosse totalmente rivolta verso una dimensione marcatamente terrena, rappresentata dall’immagine che la comunità presente alle esequie recepiva del defunto. Il ricordo che i contemporanei prima e i posteri poi conservavano delle azioni umane costituiva l’unico aspetto a suscitare interesse. Proprio alla tenuta di questo ricordo sul sistema percettivo e cognitivo dei partecipanti alla cerimonia, favorita dalla dimensione sensoriale ed emozionale espressa durante l’attuazione del rito, era affidata la sola forma possibile di immortalità.
Lo studio riguarda nove sepolture in cinque necropoli, distribuite tra l’Italia settentrionale e l’Italia centrale. Dall’analisi emergono alcune ricorrenze: quando la sepoltura animale appare associata ad un’inumazione umana, la carcassa risulta intera e interpretabile come parte del corredo del defunto; quando al contrario non è possibile identificare una correlazione, i resti scheletrici appaiono incompleti, acefali. Tali ritrovamenti possono essere ricondotti ad una pratica di sacrificio rituale. Quali sono le ragioni sociali e culturali che sostengono un simile rito, e come doveva strutturarsi il suo svolgimento, secondo la sua ricostruzione?
Le caratteristiche mostrate dalle fosse animali associate ad una specifica sepoltura umana, sia nella forma contestuale sia nella modalità separata, consentono di considerare i depositi in questione quali parte integrante del corredo funerario attribuito al defunto. Il trattamento riservato agli animali doveva rientrare a pieno titolo all’interno della pratica funeraria organizzata per il morto. Ad essere abbattuti nell’ambito del rituale potevano essere cavalli e cani, anche in combinazione tra di loro. L’atto doveva avvenire verosimilmente nelle immediate vicinanze della fossa, anche per ovviare alle difficoltà logistiche di trasportare per lunghi tratti una carcassa che poteva mostrare anche grandi dimensioni. L’uccisione era praticata secondo modalità ben precise, che mostrano una certa attenzione per l’animale, di cui si cercavano di preservare l’integrità corporea e le proprietà fisiche. Alcune caratteristiche mostrate dalle sepolture animali prive di una associazione chiara ed evidente con una specifica inumazione umana, consentono di considerare i rinvenimenti in questione quali esito ultimo di un sacrificio rituale. Più aspetti consentono di riconoscere nel taglio della testa dell’animale, una delle azioni in cui doveva articolarsi un complesso rito sacrificale compiuto in onore della divinità. La decapitazione comportava la completa distruzione dell’esemplare, qualificando il gesto come un atto sacrificale. Siamo di fronte ad un cerimoniale a sfondo religioso dalla forte valenza simbolica, chiaramente alternativo alla ritualità funeraria organizzata in onore di un membro della élite guerriera. Oltre che la decapitazione dell’animale e la probabile combustione di alcune parti molli dell’equino, il sacrificio poteva prevedere l’esposizione rituale del cranio del cavallo, magari collocato sulla sommità di una picca. Solo dopo un periodo di tempo più o meno lungo, il cranio poteva essere rimosso e deposto in una sepoltura dedicata.
Una sepoltura in particolare mostra una peculiarità. Oltre al cranio, lo scheletro del cavallo manca anche della parte terminale degli arti, dello sterno e delle vertebre caudali. Al pari delle altre inumazioni, anche l’asportazione di queste parti dipende da un’attività intenzionale. La sua ipotesi è che tali caratteristiche rimandino a qualcosa di simile ad una pratica rituale nota come “Head and Hoof”, che prevede l’esposizione per un tempo più o meno lungo della pelle dell’animale montata su un’impalcatura di legno. Come si può collocare l’origine di questa pratica, e quali significati doveva riconoscere in essa la comunità che la attuava?
Il rituale noto come Head and Hoof risulta molto diffuso in diversi periodi cronologici e in differenti ambiti culturali. La deposizione di ossa selezionate di equino è particolarmente attestata soprattutto nella zona caucasica durante la prima metà del secolo V, ma appare attestata, seppur in modo sporadico, anche in territorio europeo fino alla fine del secolo VII. Il sacrificio del cavallo sembra riflettere una religiosità strettamente legata ad una dimensione tribale e pagana, che ancora alla fine del secolo VI doveva essere molto sentita tra la popolazione longobarda. E’ parso possibile riconoscere in Freyr la divinità destinataria del rituale. Appartenente alla stirpe dei Vani, patroni della fecondità, della pace, della ricchezza e del piacere, il dio Freyr doveva rivestire un ruolo centrale nel pantheon longobardo. L’abbattimento di un equino, animale sacro alla divinità, possono essere considerati pertanto parte di un rituale strettamente legato al concetto di procreazione e di fortuna. Un gesto benaugurale perla collettività, con una chiara funzione apotropaica.
Già numerosi studi, non esclusivamente archeologici, hanno evidenziato il legame che sussiste nelle società tribali tra l’attività venatoria e l’attività militare. Questo rapporto sembra essere largamente presente anche nella comunità longobarda della fine del VI secolo. Lo troviamo infatti sia al livello del corredo, in cui cavalli e cani qualificano il defunto come cacciatore-guerriero, sia al livello dell’offerta rituale, a partire almeno dalla diffusione di una religiosità in cui gli apporti delle culture venatorie e pastorali occupano una parte decisamente più consistente rispetto a quelli provenienti dalle culture agricole. In che misura, dunque, la caccia e la guerra appaiono correlate nella società longobarda? In che modo la ritualità esprime tale rapporto?
Guerra e caccia. Nelle culture barbariche queste attività costituivano aspetti di una stessa morale, strettamente legati all’esercizio del potere. In una società semi nomade come fu quella longobarda fino alla fine del secolo VI, tali attività rappresentavano una delle principali occupazioni della élite. La caccia, soprattutto di animali feroci, era sentita come somigliante alla guerra, vero e proprio addestramento ad essa. Le pratiche e le tecniche delle due occupazioni risultavano tra loro assai simili. In una società altamente instabile e competitiva come quella longobarda della seconda metà del secolo VI, dove lo status sociale della persona deceduta poteva essere mantenuto dal rispettivo gruppo parentale unicamente tramite l’ostentazione della ricchezza, la sepoltura di animali nell’ambito del cerimoniale funebre doveva qualificare pertanto il defunto come un personaggio di grande rilievo.
Per l’acquisto del volume (18€) rivolgersi all’indirizzo: daidalos.edizioni@libero.it

da Samuele Strati | Apr 22, 2023 | Autori, Filosofia, Letteratura, Umano
«Se mi chiedessero qual è l’atteggiamento generale nei confronti degli animali che mangiamo, direi: il disprezzo. Li trattiamo male perché li disprezziamo; li disprezziamo perché non si ribellano»
Si provi a seguire J. M. Coetzee nella sua medesima proposta: La vita degli animali (1999) raccoglie le Tanner Lectures di Princeton del 1997-1998, le quali sono tuttavia tenute, e presentate successivamente al lettore, in forma di racconto. La relatrice è Elizabeth Costello, scrittrice, anziana, in visita all’Appleton College per presentare due conferenze sul tema del trattamento che la società riserva agli animali.
La prima, I filosofi e gli animali, contiene la critica al «grande discorso» del pensiero occidentale, il quale altro non sembra essere che una sorta di mitologia della separazione, un racconto sull’origine dell’uomo come opposto dell’animale. È un discorso che esalta la ragione sopra ogni cosa, e che riconosce nella specificità umana il suo principio conservativo. Esso ha decretato l’identità dell’universo e della ragione che lo comprende, escludendo quindi gli animali – nel presupposto che in questi la ragione non alberghi – dalla partecipazione alla natura di questa gloriosa unione. «L’universo è costruito sulla ragione. Dio è un Dio di ragione. Il fatto che grazie alla ragione si possa arrivare a comprendere le leggi che regolano l’universo dimostra che la ragione e l’universo hanno la stessa essenza».
Ma, prosegue Costello, la ragione coincide, al più, con l’uomo. Non l’essenza dell’universo, dunque, ma di chi, grazie ad essa e attraverso essa, lo pensa. Perciò il criterio della razionalità le appare in fondo tautologico: «Certo, la ragione riconosce la validità della ragione in quanto principio primario dell’universo: che altro dovrebbe fare? Detronizzare se stessa? I sistemi razionali, in quanto sistemi di totalità, non hanno quel potere. Se ci fosse una posizione dalla quale la ragione potesse attaccare e detronizzare se stessa, essa l’avrebbe già occupata, altrimenti non sarebbe totale».
Nelle relazioni con gli altri animali si è voluto di nuovo consacrare la validità della ragione adottandola come unità di misura per la valutazione delle loro facoltà cognitive. Qui, forse, Coetzee avanza una delle critiche più interessanti agli esperimenti sulle capacità mentali dei non umani. Nella seconda conferenza, dedicata alla poesia, Costello afferma che sono gli stessi esperimenti a non avere senso, nella misura in cui, strutturati come sono, tentano di rilevare una presenza di astrazione che non corrisponde alla reale comprensione del mondo da parte dell’intelligenza che vi si trova immersa. Tragicamente antropocentrici, in essi si dà importanza a criteri destinati a mancare il bersaglio. «C’è qualcosa di stolido nel modo in cui il behaviorismo scientifico indietreggia di fronte alla complessità della vita». Con altre parole, qualche pagina prima, gli animali vengono spinti «a pensare la cosa meno interessante».
Contestando il famoso esempio del pipistrello di T. Nagel, che si chiedeva «what is it like to be a bat?», la letterata dà la propria soluzione. Al cogito, al pensiero, Costello oppone la pienezza dell’essere, ovvero l’esperienza di essere, la sensazione di essere un corpo vivo, solido, esteso, spazialmente collocato in un mondo in cui perlomeno, se non si possiede astrattamente la nozione di vita, si ha la presenza a sé della propria vita – perciò la protagonista si appella a questo concetto impiegando anche il termine gioia. Ed è una condizione sperimentabile: in prima persona, naturalmente – ma Coetzee è chiaro: non si tratta di chiedersi cosa l’uomo e gli animali abbiano di comune – e per mezzo dell’empatia. Costello risponde alla sconsolatezza di Nagel rinvigorendo pubblicamente la fiducia nella capacità di «entrare col pensiero nell’essere di un altro», che lei dichiara illimitata.
La decisione stilistica di presentare una riflessione nella forma del romanzo ci consente inoltre di ragionare sui personaggi che la formulano. Possiamo dunque provare ad immaginare come debba essere la vita di Elizabeth Costello, che forse non ha visto l’orrore, il miserevole orrore della vita degli animali, e nondimeno sa che esso esiste, e che esiste per lei nella forma persecutoria di un’irrespirabilità generale che le rende ostile ogni spazio – fisico o sociale – e quindi l’esistenza in senso proprio. Quasi che il coltello del macellaio la minacci direttamente ad ogni passo, ad eterno memento di ciò che per sua natura, una volta scoperto, non può essere dimenticato. Costello, in viaggio con il figlio, racconta un’impressione della sua fantasia: mentre si trova a casa di amici, commenta la qualità di una lampada da salotto, per poi scoprire, dalle parole inorgoglite dei suoi ospiti, che questa è fatta con la pelle di un’ebrea polacca. A noi non resta che immaginare una metamorfosi dei volti, improvvisamente fattisi caricature grottesche, e provare un incrollabile desiderio di fuga. Ma la nostra protagonista non ha caricature di fronte a sé: si muove nella società come chiunque, e con la stessa chiarezza con cui sa cosa si conduce nel substrato nascosto della vita civile – il massacro, il crimine, la «guerra agli animali» – sperimenta anche la perfetta normalità dei rapporti.
Il dolore, unito allo smarrimento, all’impossibilità di stare nel luogo in cui ci si trova, conduce ad un avvilente senso di sconfitta. Costello non risulta vincitrice nei suoi incontri all’Appleton College. Non ne risulta neanche perdente, e infine tutto si risolve in un ripristino dello stato iniziale. Le conferenze somigliano a una grande parentesi che rimane significativa solo finché è aperta. Una volta chiusa, la vita riprende in maniera identica a come scorreva in precedenza. John Bernard, il figlio di Costello discute con sua moglie Norma, la quale non ha la scrittrice in simpatia e sopporta con malcelato fastidio la sua presenza. È lui a proferire le parole definitive: quando sua madre se ne sarà andata «torneremo alla normalità». John e Norma non si rivolgono direttamente all’anziana relatrice, eppure la sensazione è che lei li abbia uditi, e che una volta in viaggio confermi con le sue angosce le parole del figlio.
La denuncia di Costello viene freddamente (cortesemente) ricevuta dall’attenzione dell’uditorio, ma non sembra realmente infrangere il muro dell’imperturbabilità. E dove Costello rivela la propria incapacità di comprendere in se stessa la tragica verità sulla vita che gli animali conducono, fuori la reazione è talvolta del tutto ostile. Per Norma, la sua astensione dalla carne è «una fisima nei confronti del cibo» che si traduce rapidamente in un esercizio di potere – salvo poi tradirsi da sé: se questo è un gioco di potere, Norma ne fa parte, temendo segretamente di perdere il proprio, in particolare nei confronti dei figli. «Avrei più rispetto per lei se non cercasse di accoltellarmi alle spalle con le storie che racconta ai bambini sui poveri vitellini e quello che fanno loro gli uomini cattivi. […] È un gioco malsano, non voglio che i bambini lo facciano con me». Ma la parentesi si chiude: dopodiché, Costello torna al suo dolore e al suo smarrimento, ovvero alla condizione da cui il potere non può più essere esercitato.
In più di un punto Coetzee lascia intendere una difficoltà autentica nella ricerca delle ragioni reali dell’orrore. Lo sterminio non sembra rispondere, nella sua vera essenza, alle logiche del mercato, né a quelle della natura. La risposta va forse cercata entro una dimensione spirituale. Quando, durante la cena al Circolo della Facoltà, il rettore le domanda se il suo vegetarianismo abbia un’origine morale, lei risponde negativamente. «Nasce dal desiderio di salvarmi l’anima», dice. L’impressione, triste, è che al contrario la salvezza rifugga Elizabeth Costello, alla quale non rimane che cedere a un pianto sommesso.

da Samuele Strati | Apr 1, 2023 | Antropologia, Etologia, Filosofia, Scienze, Umano
Ben poche volte si è mancato di far notare nelle scienze della vita e degli organismi come l’osservazione delle numerose forme viventi che popolano il pianeta, delle loro diversità e similitudini, consonanze e divergenze morfologiche, dei loro rapporti con gli ambienti in cui si trovano a vivere, e ancora maggiormente il loro studio, che consente l’accesso alle strutture fondamentali e minute dei corpi, mettano in luce un eccezionale grado di unità e di compatibilità. Infiniti sono gli esempi di organismi, o parti di questi, che appaiono perfettamente organizzati per la vita che conducono: le strutture alari degli uccelli e degli insetti, gli occhi adattati degli animali notturni, le qualità idrodinamiche di molte creature acquatiche; nel regno vegetale si riscontrano continuamente geometrie, rapporti matematici, equilibri, distribuzioni.
Simili osservazioni possono condurre all’impressione – ben lontana dall’essere stata ignorata storicamente – che vi sia in queste forme un carattere di completezza, diremo meglio, qualcosa di eminentemente concluso. Scegliamo di impiegare questo termine, in virtù della sua immediata capacità riassuntiva, per designare una forma – o un sistema – immutabile e fissa, perché progettata nel modo in cui si presenta all’osservatore o perché corrispondente ad un archetipo; in ogni caso, priva della possibilità plastica di modificare se stessa o la propria discendenza nel corso del tempo. Una forma, cioè, realizzata, e dunque conclusa, compiuta e perciò incapace di compiersi ulteriormente.
Questo modo di intendere la realtà vivente è proprio, ad esempio, anche se non esclusivamente, delle interpretazioni creazioniste, che noi raccogliamo in un senso ampio e generale, dal momento che esse comprendono in realtà una serie di posizioni variegate, alcune delle quali, soprattutto dopo la seconda metà del diciannovesimo secolo e per tutto il ventesimo, ammettono l’evoluzione delle specie (es. Teilhard de Chardin. In generale, sui rapporti tra evoluzionismo e teologia cattolica cfr. Molari 1984; sulla disputa tra evoluzionismo e creazionismo nell’età di Darwin cfr. Casini 2009), e alcune che, in secoli più remoti, non furono comunque insensibili a problemi di difficile soluzione teologica, come la presenza negli strati fossili di resti di creature decisamente distanti da quelle attuali (una su tutte, la teoria delle catastrofi sostenuta da Cuvier nel Discours sur les révolutions de la surface du globe del 1812, per cui il pianeta avrebbe subìto una serie di sconvolgimenti geologici al termine dei quali la vita sarebbe stata, di volta in volta, creata nuovamente). Noi ci limitiamo ad intendere il creazionismo entro una formula generica e accostabile a quella presentata da Paley nella Natural Theology (1802), in cui le specie appaiono immutabili e statiche, “concluse” perché create ab initio da una volontà che pensa e dice(1) la propria Creazione e la dispone provvidenzialmente, in ogni sua parte, alla vita materiale.
L’evoluzionismo introduce, al contrario, il principio del trasformismo delle specie. La teoria classica, darwiniana, prevede che la discendenza degli organismi si modifichi in risposta a certe pressioni ambientali. Il rapporto tra l’organismo e l’ambiente in cui questo si trova produce un esito selettivo che nel corso del tempo e delle generazioni conduce alla trasformazione degli organismi stessi nelle loro qualità genetiche, morfologiche ed etologiche. In questo processo, ininterrotto e privo di direzionalità, giacché dipendente da una serie aleatoria di eventi, nessuna forma è mai dunque definitivamente conclusa, ovvero fissata nel tempo – nel senso creazionistico che abbiamo visto. La relazione tra organismo e ambiente è di natura evidentemente circostanziale, e una volta stabilita una simile interpretazione dei fatti relativi alla discendenza le difficoltà teoretiche che si incontrano nel tentativo di risalire ad una sorta di disegno originario sono notevoli. Se si considerano la natura e il sistema dei viventi come privi di progetto, a risentirne è il concetto stesso di conclusione, il quale è tolto dall’inizio. In Darwin il principio della selezione naturale sostituisce l’argomento teologico-finalistico: «Oggi, dopo la scoperta della legge della selezione naturale, cade il vecchio argomento di un disegno nella natura secondo quanto scriveva Paley […]. Non si può più sostenere, per esempio, che la cerniera perfetta di una conchiglia bivalve debba essere stata ideata da un essere intelligente, come la cerniera della porta dall’uomo» (Darwin 2016, 69). Così, l’interpretazione fissista, che pensa l’immutabilità delle specie nel tempo, viene corretta da una visione genealogica del mondo vivente. In questa, la vita e i suoi accadimenti si presentano alla maniera di un processo.
Tale scoperta, che storicamente si traduce in una presa di coscienza circa il fatto che il sistema degli organismi possiede una propria logica e un proprio funzionamento intrinseco (e che non si limita, dunque, a rispecchiare una disposizione dettata dall’esterno), ha dovuto imporre una prospettiva e nuove direzioni di ricerca ad una serie di problemi su cui tanto la filosofia, quanto le scienze naturali si sono a lungo soffermate, e che anche precedentemente non erano stati ignorati: tra i molti, il problema del determinismo e della libertà dell’agire, della percezione e dell’esperienza, dell’origine delle facoltà cognitive e del senso estetico, e non da ultimi i dilemmi teologici relativi al senso della vita nel suo complesso, e tra questi, ancora, quelli legati alla vita precedente alla comparsa della nostra specie. Nel caso specifico dell’essere umano si trovano interrogate direttamente tutte le questioni che ricadono sotto il dominio dell’antropologia filosofica, a partire da come debba essere inteso il fatto puro della presenza umana nell’ordine delle cose naturali. Quando si voglia compiere sull’uomo un discorso sistematico, comprensivo di tutto quanto è necessario dire affinché se ne possa ottenere una conoscenza completa al massimo delle possibilità, come se visivamente lo si inquadrasse in un campo largo, e specialmente laddove si voglia discutere la questione vitale della sua posizione nel mondo e nel cosmo, il riconoscimento di questa dimensione evolutiva non può essere eluso.
(1) Ci riferiamo all’espressione «Dio disse:» contenuta nella Genesi (Gn 1, 1-30), in cui l’atto creativo è sempre preceduto dalla sua affermazione.
Riferimenti:
P. Casini, Darwin e la disputa sulla creazione, Il Mulino, Bologna 2009.
C. Darwin, Autobiografia (1809-1882), Einaudi, Torino 2016.
C. Molari, Darwinismo e teologia cattolica. Un secolo di conflitti, Borla, Roma 1984.